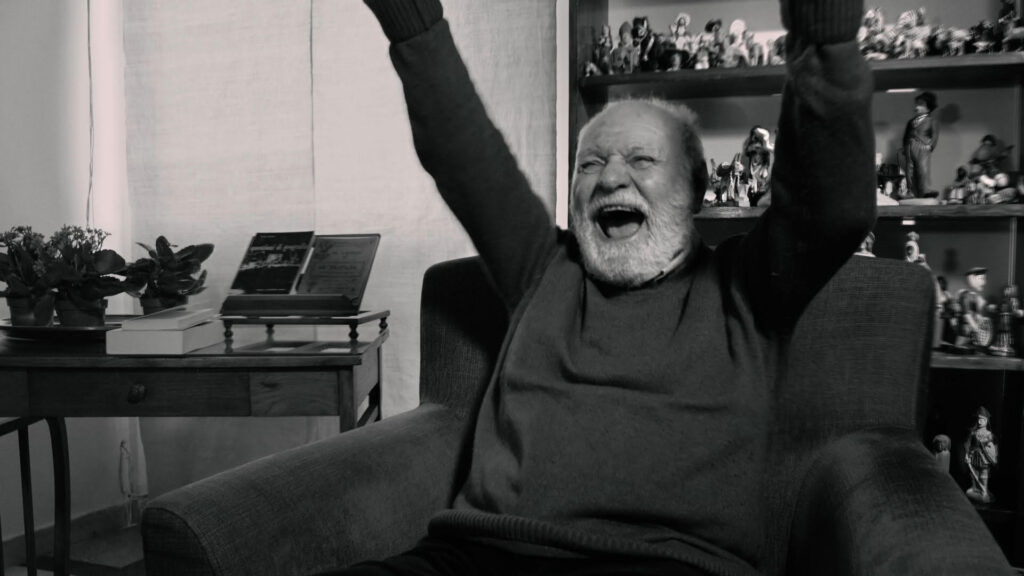Goffredo Fofi, scomparso all’età di 88 anni, è stato una delle figure più originali e anticonformiste dell’a cultura italiana, ricordato soprattutto per il suo fondamentale contributo alla rivalutazione di Totò, attore spesso snobbato in vita dalla critica cinematografica, per la sua “popolarità”. Nel documentario Suole al vento di Felice Pesoli, Fofi raccontò un aneddoto gustoso sul suo rapporto indelebile col principe della risata. Come riportato da Il Manifesto, disse che a un certo punto non ne poteva più di essere chiamato a parlare di Totò. Così, quando un giorno arrivò l’ennesimo invito, decise di rifiutare. Appena prese il telefono per comunicare la scelta, un quadretto di Totò cadde a terra. Fori tornò sui suoi passi si rimangia il rifiuto.
Nato a Gubbio il 15 aprile 1937, Fofi crebbe in una famiglia di condizioni modeste ma ricca di stimoli culturali. Il padre, un artigiano socialista che riparava biciclette, aveva trasmesso al figlio l’amore per i libri e il cinema. La sua formazione fu segnata dall’esperienza traumatica della guerra, durante la quale assistette agli orrori nazisti nella sua città natale.
A soli diciotto anni, nel 1955, Fofi partì per la Sicilia per unirsi alle battaglie non violente di Danilo Dolci, il “Gandhi italiano”. Qui partecipò ai cosiddetti “scioperi a rovescio”, organizzando spontaneamente lavori pubblici trascurati dalle autorità, finendo anche sotto processo per disobbedienza civile. L’esperienza siciliana, dedicata ai bambini in stato di abbandono, rimase uno dei periodi più felici della sua vita.
Trasferitosi a Torino, Fofi continuò a occuparsi delle questioni sociali del Mezzogiorno, pubblicando nel 1964 il suo primo libro “L’immigrazione meridionale a Torino” per Feltrinelli. Il suo sguardo critico si estese presto agli effetti del boom economico e all’omologazione culturale, temi che lo videro inizialmente in disaccordo con Pier Paolo Pasolini, salvo poi riconoscere la lungimiranza delle preoccupazioni del poeta.

L’attivismo di Fofi si espresse attraverso la direzione di riviste culturali fondamentali come “Quaderni piacentini”, “Ombre Rosse”, “Linea d’Ombra” e “Lo Straniero”, quest’ultima diretta per circa vent’anni dal 1997 al 2016 e intitolata in onore di Albert Camus. Sempre lontano dai partiti, anche dal Pci, Fofi sviluppò una visione libertaria con venature cristiane, ispirandosi a figure come Aldo Capitini e Giuseppe Mazzini.
Ma è nel campo della critica cinematografica che Fofi lasciò il segno più profondo. Nel 1968 pubblicò “Totò. L’uomo e la maschera”, realizzato con la collaborazione di Franca Faldini, compagna di vita dell’attore napoletano. Questo studio rappresentò la prima ricognizione approfondita e sofisticata del fenomeno Totò, analizzando il suo modo di intendere l’arte comica in tutte le sue sfaccettature e ascendenze.
Il lavoro di Fofi su Totò seguiva la scia di Pier Paolo Pasolini, che aveva voluto l’attore napoletano in “Uccellacci e uccellini”. La rivalutazione operata dal critico umbro fu rivoluzionaria. Trasformò la percezione di un comico considerato “minore” in quella di un autentico genio dell’arte cinematografica, capace di incarnare le contraddizioni e la poesia del popolo italiano.
Oltre a Totò, Fofi dedicò studi approfonditi ad altre figure centrali del cinema, da Alberto Sordi a Marlon Brando, contribuendo con opere come “Cinema italiano. Servi e padroni” (Feltrinelli, 1971) a una lettura politica e sociale del cinema nazionale. La sua collaborazione con registi come Mario Monicelli testimoniano un approccio critico mai distaccato dalla pratica cinematografica.
Vegetariano convinto e seguace della non violenza, Fofi mantenne fino all’ultimo un atteggiamento intransigente verso il potere e le prevaricazioni, sintetizzato nella formula di Capitini: “Non accetto”. Nonostante il crescente pessimismo verso la società italiana e la classe dirigente, non rinunciò mai all’impegno civile, animato da quello che definiva un “volontarismo utopistico” e dalla consapevolezza che “si ha una vita sola a disposizione”.