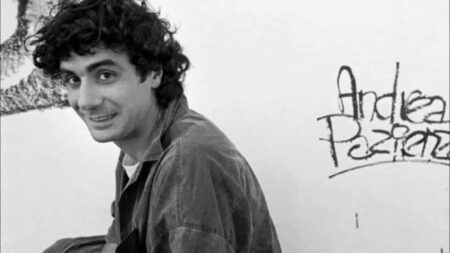Si celebra oggi, in occasione del Venerdì Santo, un antico rito che ogni anno emoziona i cattolici di tutto il mondo: si tratta della Via Crucis, la “Via della Croce”. Nato secoli fa, questo cammino spirituale ripercorre il doloroso viaggio di Gesù Cristo verso la crocifissione sul Golgota, unendo devozione, meditazione e un’intensa carica emotiva. Ma cos’è esattamente la Via Crucis, e perché è ancora così seguita dopo tanto tempo?
La Via Crucis, o Via Dolorosa, affonda le sue radici nei luoghi stessi della Passione di Cristo: si racconta che già Maria, madre di Gesù, fosse solita visitare i luoghi in cui suo figlio aveva sofferto prima di morire; la devozione religiosa nei confronti di questo percorso prende forma però nel XIII secolo con i francescani, e in particolare con San Francesco d’Assisi. Intorno al 1294, il frate domenicano Rinaldo di Monte Crucis descrive un percorso a Gerusalemme, fatto di “stazioni” che segnano momenti chiave: dalla condanna di Gesù all’incontro con le pie donne, fino alla croce.
Poiché non tutti potevano permettersi di affrontare un lungo pellegrinaggio in Terra Santa, nel XIV secolo i frati francescani iniziarono a ricreare questo cammino nelle chiese europee, portando idealmente Gerusalemme tra i fedeli. Le 14 stazioni, dipinte o scolpite, trasformavano ogni chiesa in un angolo della Via Dolorosa, permettendo a chiunque di meditare sulla Passione con il cuore e con gli occhi.
La Via Crucis è un percorso scandito da 14 momenti, o “stazioni”, che raccontano le ultime tappe del cammino di Gesù verso la crocifissione. Ogni stazione è un quadro vivo, un istante di sofferenza e umanità: Gesù condannato a morte, il peso della croce, le cadute, l’incontro con la madre, l’aiuto di Simone di Cirene, il gesto di Veronica che asciuga il suo volto; è alla fine che si arriva al culmine con la crocifissione vera e propria, la morte e la deposizione nel sepolcro.
Nel corso dei secoli queste stazioni sono state rappresentate in modi diversi: dipinti, sculture, bassorilievi e persino spettacoli viventi, come la suggestiva Via Crucis di Cianciana, in Sicilia. Ogni rappresentazione cattura l’immaginazione e invita alla riflessione, trasformando il dolore di Cristo in un’esperienza universale. Un luogo simbolo della Via Crucis moderna è il Colosseo a Roma, dove dal 1750 i papi celebrano questo rito ogni Venerdì Santo (salvo rare eccezioni, come durante la pandemia di Covid-19).

Ecco più precisamente quali sono le tradizionali 14 stazioni della Via Crucis:
- Gesù è condannato a morte;
- Gesù è caricato della croce;
- Gesù cade per la prima volta;
- Gesù incontra sua madre;
- Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene;
- Santa Veronica asciuga il volto di Gesù;
- Gesù cade una seconda volta;
- Gesù consola le donne di Gerusalemme;
- Gesù cade per la terza volta;
- Gesù è spogliato delle vesti;
- Gesù è inchiodato sulla croce;
- Gesù muore in croce;
- Gesù è deposto dalla croce;
- Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro.
La Via Crucis non è però rimasta immutata nel tempo: nel 1991, papa Giovanni Paolo II propose uno schema alternativo, più legato ai Vangeli, includendo momenti come l’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani e il rinnegamento di Pietro; anche i suoi successori l’hanno adottato in più occasioni. E c’è chi aggiunge una quindicesima stazione, la Risurrezione, anche se molti preferiscono lasciare il rito incentrato sulla Passione, riservando la gioia della Risurrezione alla Via Lucis, il cammino pasquale della luce.