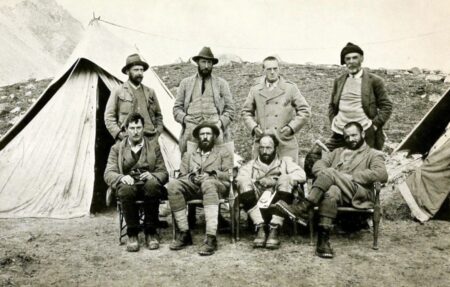Nel cuore dell’Italia del XIX secolo, una vicenda drammatica scosse le fondamenta dello Stato Pontificio e destò l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di sei anni, venne strappato alla sua famiglia per ordine della Chiesa, in seguito a un battesimo segreto effettuato da una domestica cattolica. Il suo rapimento scatenò proteste e polemiche, diventando un caso emblematico della tensione tra autorità religiosa e diritti civili. Marco Bellocchio, con “Rapito”, riporta alla luce questa storia, dai contorni tragici.

La vicenda di Edgardo Mortara ha origine nel 1851. Il piccolo nasce in una famiglia ebraica di Bologna. A causa di una malattia, la domestica cristiana, Anna Morisi, temendo per la sua anima, decide di battezzarlo di nascosto. Anni dopo, la notizia arriva alle orecchie della Santa Inquisizione, rappresentata dal domenicano Pier Gaetano Feletti. Poiché la dottrina cattolica vietava che un cristiano fosse cresciuto da genitori non cattolici, la Chiesa decise di intervenire. Nella notte del 23 giugno 1858, la polizia pontificia fece irruzione nella casa dei Mortara, strappando il piccolo Edgardo alla sua famiglia, tra le urla disperate dei genitori e dei fratelli.
Trasferito a Roma, Edgardo venne allevato nella Casa dei Catecumeni, un istituto per la conversione degli ebrei al cristianesimo. Papa Pio IX prese il bambino sotto la sua protezione, considerandosi il suo “nuovo padre”. Nonostante le suppliche incessanti della famiglia e la pressione diplomatica di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, il papa si rifiutò categoricamente di restituire Edgardo. Il bambino, isolato dal mondo e sottoposto a un’educazione cattolica rigorosa, crebbe accettando sempre più la sua nuova identità. Nel 1870, l’esercito italiano conquistò Roma e pose fine al dominio temporale della Chiesa, ma ormai il destino di Edgardo era segnato. Ordinato sacerdote a 21 anni, rimase fedele alla fede cattolica fino alla morte.
Il caso Mortara ebbe conseguenze enormi. Oltre a scuotere l’opinione pubblica ebraica e laica, contribuì a rafforzare il movimento di unificazione italiana, accelerando la fine del potere temporale del papato. L’episodio rivelò al mondo la crudeltà delle leggi pontificie e l’oppressione della comunità ebraica nello Stato della Chiesa.
Il film di Bellocchio, che in origine avrebbe dovuto essere diretto da Steven Spielberg, non è solo una cronaca storica, ma un’opera che interroga lo spettatore su temi universali: la violenza del potere, il fanatismo religioso, la lotta per la libertà e l’identità.