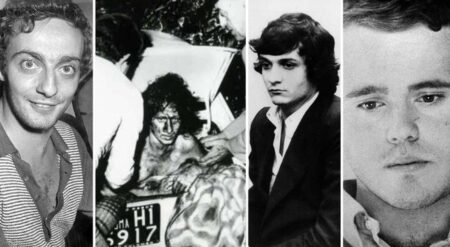Nel 1853, la regina Vittoria del Regno Unito contribuì in modo decisivo a cambiare il corso della medicina ostetrica, accettando di usare il cloroformio come anestetico durante la nascita del suo ottavo figlio, il principe Leopoldo. Questo evento ebbe un impatto profondo sulla percezione pubblica e medica del sollievo dal dolore nel parto, segnando un punto di svolta storico nella diffusione dell’anestesia moderna.
Fino alla metà del XIX secolo, il dolore del parto era considerato inevitabile e, in molti ambienti, persino necessario o moralmente “giustificato”. La medicina dell’epoca era ancora ancorata a idee religiose e culturali che ostacolavano l’adozione di metodi anestetici per le donne in travaglio. Era o no la Bibbia ad aver veicolato l’idea che la sofferenza nel parto fosse parte della condizione femminile? In questo contesto, qualsiasi tentativo di alleviare quel dolore veniva percepito con sospetto o perfino come una sfida all’ordine naturale.
Il cloroformio, scoperto nel 1831 da Samuel Guthrie e poi sviluppato come anestetico da James Young Simpson nel 1847, si affermò rapidamente come alternativa più potente e meno irritante rispetto all’etere. Simpson fu il primo a sperimentarne l’uso in ambito ostetrico, ma l’opinione pubblica e la comunità medica rimasero inizialmente divise sulla sua accettabilità morale e sicurezza clinica.
Nel 1853, durante il parto del principe Leopoldo, il medico personale della sovrana, John Snow – uno dei padri fondatori dell’anestesiologia moderna e noto anche per i suoi studi sull’epidemiologia del colera – somministrò alla regina cloroformio sotto forma di inalazione. L’operazione fu effettuata con discrezione, ma venne successivamente confermata da Snow stesso in una pubblicazione scientifica.
Il successo del parto e l’apprezzamento espresso dalla regina nei confronti del cloroformio giocarono un ruolo decisivo nel legittimare il suo uso. L’effetto più immediato fu una rapida diffusione dell’anestesia ostetrica in Gran Bretagna e in Europa.

Il cloroformio (triclormetano, CHCl₃) è un composto chimico volatile e incolore, dal tipico odore dolciastro. Agisce come depressivo del sistema nervoso centrale e induce una perdita di coscienza in pochi minuti, se inalato in dosi sufficienti. Viene assorbito rapidamente attraverso i polmoni e distribuito ai tessuti ricchi di lipidi, come il cervello.
Dal punto di vista farmacodinamico, il cloroformio agisce potenziando l’attività del neurotrasmettitore GABA nei recettori GABA-A, il che provoca un effetto sedativo e anestetico. Tuttavia, ha un margine terapeutico stretto: un dosaggio leggermente eccessivo può causare arresto respiratorio o cardiaco.
Già alla fine del XIX secolo, la tossicità epatica e cardiaca del cloroformio iniziarono a essere ben documentate. Si osservò che poteva provocare aritmie cardiache, sensibilizzazione del cuore alle catecolamine endogene, necrosi epatica e, in alcuni casi, morte improvvisa. Questi effetti portarono, nel corso del tempo, al suo progressivo abbandono in ambito clinico. Ragion per cui oggi non si utilizza più. Il gesto della regina Vittoria però, portò a una progressiva normalizzazione dell’anestesia in ostetricia.
Nonostante la successiva sostituzione del cloroformio con agenti più sicuri, come l’alotano e successivamente l’isoflurano, il suo impiego rappresentò una tappa fondamentale nel progresso dell’anestesia e, più in generale, nel riconoscimento del diritto delle donne a un parto meno doloroso.