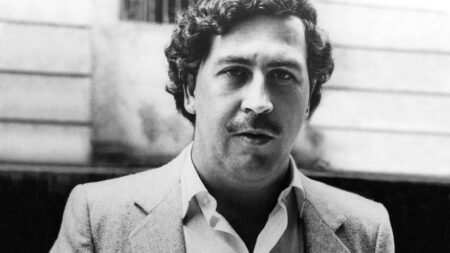Il titolo “il Magnifico” associato a Lorenzo de’ Medici non fu un appellativo casuale, ma il riconoscimento pubblico e storico di una figura che seppe incarnare al massimo grado l’ideale dell’uomo rinascimentale. Nei documenti e nelle testimonianze dell’epoca, il termine veniva usato per esprimere ammirazione per la sua abilità di governare, il suo straordinario mecenatismo e la sua capacità di far fiorire le arti a Firenze. Nato nel capoluogo toscano nel 1449, Lorenzo fu il rappresentante più illustre della dinastia medicea nel Quattrocento.
L’aggettivo magnifico, in uso tra i ceti dirigenti del tempo, indicava già nel linguaggio formale dell’epoca una persona di grande prestigio, dotata di virtù civiche e generosità. Tuttavia, nel caso di Lorenzo, assunse una connotazione eccezionale. Come scrive lo storico Nicolai Rubinstein, la sua “magnificenza” fu riconosciuta per la capacità di esercitare il potere senza cariche ufficiali, mantenendo un controllo effettivo sulla Repubblica fiorentina attraverso una rete di alleanze politiche e clientelari.
Lorenzo non fu un sovrano nel senso tradizionale, ma un abile tessitore di equilibri. Dopo la Congiura dei Pazzi (1478), che mirava a eliminare lui e il fratello Giuliano, Lorenzo assunse un ruolo sempre più diretto nella guida politica della città, mantenendo però le apparenze repubblicane. In un’epoca segnata da guerre e instabilità, riuscì a garantire a Firenze un periodo di relativa pace e prosperità economica.

Il suo contributo alla cultura fu determinante. Lorenzo fu mecenate di artisti e intellettuali come Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e il filosofo Marsilio Ficino. La sua corte divenne un centro vitale del Rinascimento italiano. Il suo sostegno alla diffusione del neoplatonismo e la promozione di opere classiche, sia letterarie che artistiche, contribuirono in modo decisivo alla fioritura culturale del periodo.
Lorenzo stesso fu poeta e scrittore. Le sue composizioni, tra cui i celebri Canti carnascialeschi, testimoniano la sua sensibilità artistica e il suo ruolo attivo nella scena culturale del tempo. La sua produzione letteraria univa motivi sacri e profani, colti e popolari, anticipando temi che sarebbero diventati centrali nella cultura umanistica. Tra le sue opere più celebri c’è la poesia La canzona di Bacco, nota per il verso
“Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non c’è certezza“
Insomma, Lorenzo de’ Medici fu detto “il Magnifico” per una somma di motivi: l’abilità politica, il ruolo di mecenate, il contributo diretto alla letteratura e alla filosofia, e l’ideale civico che seppe incarnare.
Lorenzo morì l’8 aprile 1492, qualche mese prima della scoperta delle Americhe, a soli 42 anni, probabilmente per una cancrena causata da un’ulcera a sua volta favorita dalla gotta. Al suo fianco, circondato Poliziano e Pico Della Mirandola, altro esponente formidabile della cultura rinascimentale, dalla memoria prodigiosa.