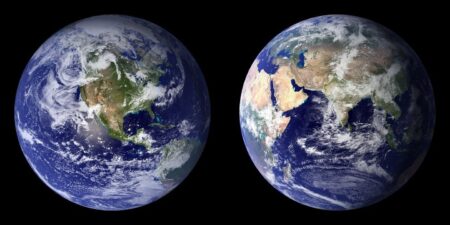Per oltre cinquant’anni, chi subiva un trauma cranico veniva valutato secondo un’unica scala: la Glasgow Coma Scale. Ma questo sistema, che divide i pazienti in “lievi”, “moderati” e “gravi” basandosi principalmente sul livello di coscienza, si è rivelato troppo semplice per affrontare la complessità reale di questi casi. Ora un nuovo metodo, più dettagliato e completo, è stato proposto per migliorare la diagnosi, guidare meglio le cure e salvare vite umane.
Il nuovo approccio si chiama CBI-M framework ed è stato sviluppato da un gruppo internazionale di esperti, medici, pazienti e ricercatori provenienti da 14 paesi. Questo sistema tiene conto non solo dello stato di coscienza del paziente, ma anche di esami del sangue, immagini diagnostiche e fattori personali o sociali che possono influenzare la guarigione.
Il primo pilastro del sistema rimane la valutazione clinica, ma viene ampliata. Oltre al punteggio GCS, si analizzano la reazione delle pupille, la presenza di sintomi come vertigini, mal di testa o sensibilità ai suoni, e anche la memoria del paziente. Questa fase è considerata prioritaria, perché da sola può già fornire preziose indicazioni sulla gravità del danno cerebrale.
Il secondo pilastro riguarda i biomarcatori, cioè alcune sostanze misurabili nel sangue entro 24 ore dall’incidente. In particolare, si analizzano tre proteine: GFAP, UCH-L1 e S100B. Livelli bassi di queste sostanze indicano con grande precisione un rischio molto basso di danni cerebrali visibili alla TAC, e quindi possono aiutare a evitare esami inutili e costosi.
Il terzo pilastro è l’imaging cerebrale, cioè l’uso di esami come la TAC e la risonanza magnetica (RM). La TAC resta l’esame più usato nelle prime ore dopo il trauma, ma la RM, anche se più complessa da eseguire, è molto più sensibile e può rivelare danni invisibili alla TAC. L’utilizzo combinato di questi strumenti aiuta a capire meglio l’estensione del danno.
Il quarto e ultimo pilastro è quello dei modificatori, cioè tutte le informazioni aggiuntive che possono influenzare la prognosi. Qui si considerano elementi come l’età, il sesso, eventuali disturbi mentali preesistenti, uso di farmaci o droghe, la presenza di supporto familiare, precedenti traumi cranici e perfino le condizioni di vita del paziente. Questi aspetti non cambiano l’esito degli esami, ma servono a interpretare meglio i risultati e a fare previsioni più accurate sui tempi e le modalità di recupero.
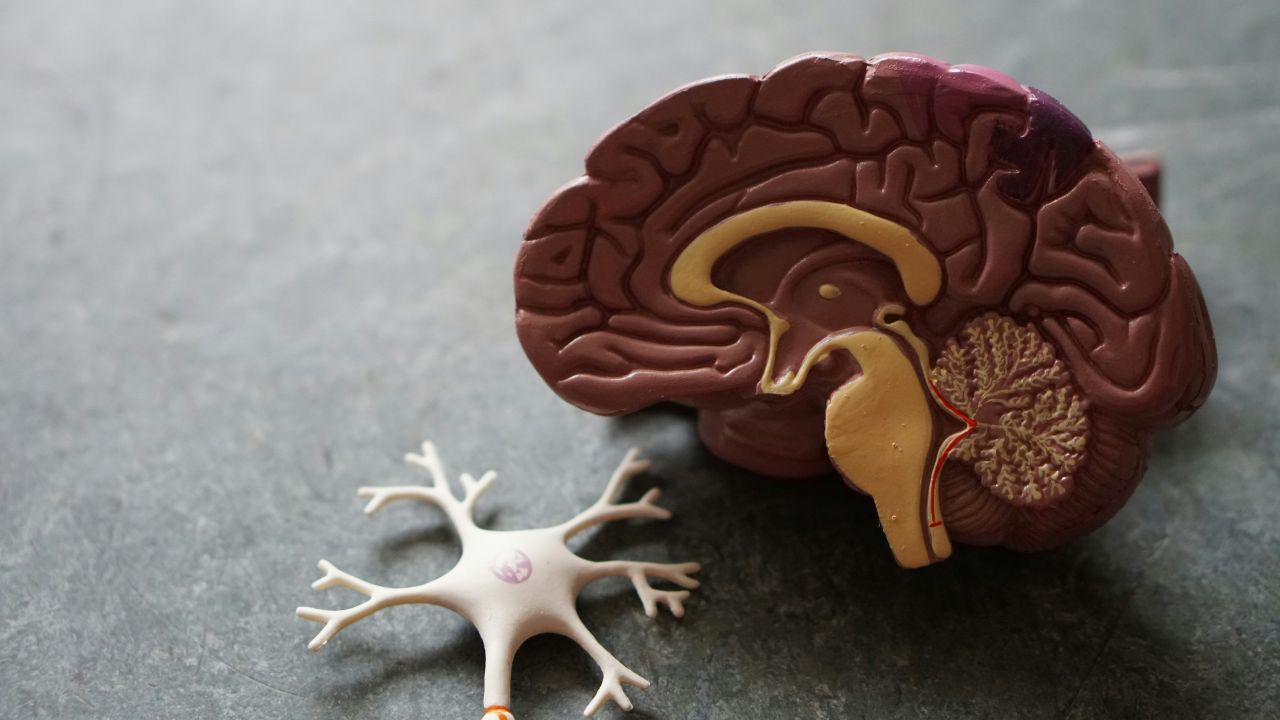
Uno degli scopi principali del nuovo sistema è evitare diagnosi troppo generiche o fuorvianti. Attualmente, capita spesso che una persona con trauma cranico lieve venga rimandata a casa con la raccomandazione di riprendere le attività dopo pochi giorni. Ma a distanza di settimane può ancora soffrire di mal di testa, disturbi visivi, insonnia o depressione. Allo stesso tempo, ci sono pazienti classificati come gravi a cui viene sospesa la terapia troppo presto, quando invece avrebbero potuto recuperare se seguiti adeguatamente.
Il nuovo metodo consente ai medici di raccogliere una descrizione molto più precisa del paziente.
Tuttavia, il sistema CBI-M non è ancora perfetto. Alcuni esperti hanno espresso perplessità sulla reale utilità dei biomarcatori, che richiedono tempo e laboratori specializzati, e che sono difficili da usare nei paesi meno ricchi. Anche il pilastro dei “modificatori” è molto utile per prevedere come andrà il recupero, ma ha un impatto limitato nelle prime ore, quando bisogna prendere decisioni rapide.
Un’altra critica è che il nuovo sistema, per ora, non include la misurazione della pressione intracranica, un parametro essenziale nei casi più gravi. I creatori del framework spiegano però che questo metodo vuole essere applicabile in ogni contesto, anche fuori dalle terapie intensive, e quindi include solo elementi che si possono usare ovunque.
Il CBI-M framework è attualmente in fase di sperimentazione in diversi centri trauma e verrà perfezionato nei prossimi anni.