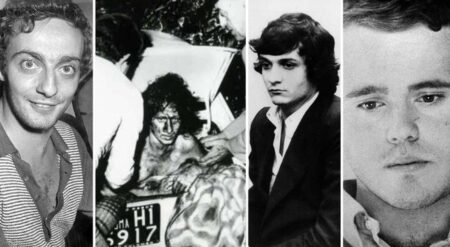Nell’anno 79 d.C., in una tranquilla giornata d’estate, il cielo sopra Pompei si oscurò improvvisamente, e il Vesuvio si risvegliò con una furia che avrebbe segnato la storia: l’eruzione del 79 d.C. fu un evento che congelò nel tempo città fiorenti come Pompei ed Ercolano, lasciando una tragica ma affascinante istantanea della vita romana dell’epoca. Ripercorriamo insieme le ore drammatiche in cui, tra nuvole di cenere e fiumi di fango, si dipanò una catastrofe che distrusse intere comunità e che continua a parlare al presente.
Fu probabilmente il 24 agosto, secondo le fonti tradizionali – per quanto alcuni studi suggeriscano si sia trattato di ottobre – che il Vesuvio eruttò con una violenza inaudita. Plinio il Giovane, testimone oculare da Miseno, descrisse una colonna di fumo e cenere alta chilometri, che oscurò il sole come un’eclissi. Pompei, Ercolano e Stabia, città vivaci ai piedi del vulcano, furono colte alla sprovvista. Per diverse ore una pioggia di pomici e cenere cadde sulle strade, costringendo gli abitanti a rifugiarsi nelle proprie case o a fuggire verso il mare. Ma il peggio doveva ancora venire.
Verso l’alba del giorno successivo, un’ondata di gas incandescenti e cenere nota oggi come flusso piroclastico, travolse tutto: a Pompei la temperatura raggiunse i 300° C, uccidendo all’istante chi non era già morto soffocato dalla cenere; studi più recenti parlano persino di 530°, una temperatura in grado di produrre fenomeni come la vetrificazione dei tessuti. Ercolano fu sepolta da un’ondata di fango vulcanico, che sigillò la città sotto uno strato di 20 metri. In poche ore migliaia di persone persero la vita: mercanti, schiavi, nobili, tutti uniti dallo stesso destino. Si stima che a Pompei ed Ercolano morirono tra le 10.000 e le 15.000 persone, anche se il numero esatto resta un mistero.

L’eruzione non si limitò a distruggere, ma paradossalmente fu in grado anche di preservare: la cenere e il fango che seppellirono le città le protessero dall’oblio, trasformando Pompei ed Ercolano in due tragiche capsule del tempo. Gli scavi, iniziati nel XVIII secolo, hanno riportato alla luce case, botteghe, templi e persino il pane ancora nei forni. I calchi dei corpi, creati versando gesso nelle cavità lasciate dai cadaveri nella cenere, mostrano madri che abbracciano i figli, amanti stretti l’uno all’altro, un cane legato a una catena. Ogni calco racconta una storia di paura, speranza e umanità.
Tra i dettagli più toccanti troviamo graffiti che parlano di amori e litigi, mosaici che celebrano la bellezza e oggetti quotidiani come gioielli e anfore di vino. Plinio il Vecchio, zio del Giovane, morì tentando di salvare i sopravvissuti via mare, vittima del suo stesso coraggio. La sua testimonianza, insieme alle lettere del nipote, resta una delle cronache più vivide di questo disastro naturale dell’antichità.
L’eruzione del Vesuvio segnò dunque la fine di un’epoca per queste città campane, ma anche l’inizio della loro immortalità: oggi Pompei è uno dei siti archeologici più visitati al mondo, un luogo che ci ricorda la fragilità della vita e la potenza della natura, con il Vesuvio ancora attivo che continua a sovrastare su Napoli e dintorni e gli scienziati intenti a studiarne il passato per prevederne il futuro.